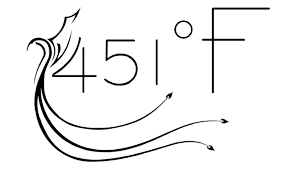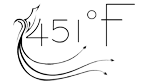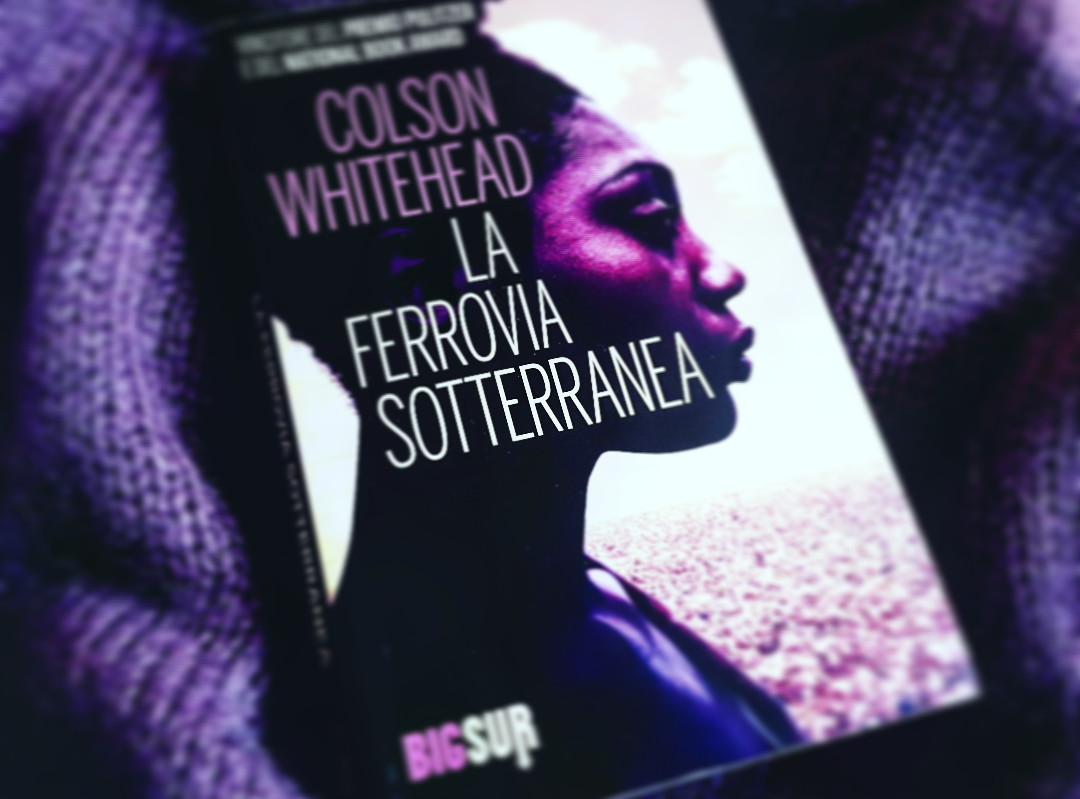La ferrovia sotterranea
di Colson Whitehead
“La prima e l’ultima cosa che diede alla figlia furono delle scuse.
Cora dormiva ancora dentro la sua pancia , piccola come un pugno,
quando Mabel si scusò per il mondo in cui l’avrebbe fatta nascere.
Cora dormiva accanto a lei sul solaio , dieci anni dopo, quando Mabel si scusò perché la stava per abbandonare. Nessuna delle due volte Cora la sentì.”
È viola la copertina, con un profilo di donna afroamericana dallo sguardo fisso, fiero, impassibile, duro e leggermente rivolto verso il basso.
Forse rimanda al viola del campo di fiori descritto da Alice Walke, capace di riportare il sorriso a due sorelle vessate dalla cultura razzista e maschilista imperante nella Georgia di inizio Novecento o, forse, è il viola della pioggia cantata da Prince – per il quale era colore simbolo di rinascita e speranza – e ascoltata da Colson Whitehead ogni volta che è in procinto di terminare la stesura di un libro. Così è avvenuto anche per La ferrovia sotterranea (Sur Edizioni), vincitore del Pulitzer per la narrativa 2017 e del National Book Award.
Forse il volto è quello di Cora, la protagonista del romanzo ambientato in Georgia nella prima metà dell’Ottocento.
Quindici anni, schiava, una “randagia” da quando dieci anni prima fu abbandonata dalla madre, Cora fugge dalla piantagione di cotone insieme con l’amico Caesar, intraprendendo un allucinante viaggio della speranza verso la libertà del “Nord”, braccata da uno spietato cacciatore di taglie e attraverso una rete clandestina tessuta da attivisti abolizionisti: la ferrovia sotterranea, storicamente esistita. Locuzione che, grazie ad un indovinato espediente letterario, l’autore statunitense svuota della valenza metaforica conferendole corpo fisico, dotandola di ruote, binari, banchine, carrelli, gallerie, tunnel manovrati e gestiti da capistazione e capitreno simpatizzanti. Una reale infrastruttura sotterranea con un proprio, talvolta precario, potere locomotore salvifico.
Dopo la satira sulla schiavitù di Paul Beatty con Lo schiavista nel 2016, Whitehead sceglie un taglio quasi documentaristico – nonostante l’introduzione di quell’elemento immaginario – narrando con distanza incalzante e con lucida dovizia di particolari uno spaccato storico i cui cascami vivono tuttora. La lente d’ingrandimento, opportunamente documentata, si sofferma, infatti, sui dettagli della genesi etnica del Nuovo Mondo, dell’ambientazione, dell’abbigliamento, delle punizioni, delle torture, degli usi, degli abusi disumani, delle angherie “così fantasiose nella loro mostruosità che la mente si rifiutava di contenere”.
Nel ricordare gli edificatori e i fruitori di “quell’opera magnifica, di quel miracolo“, Whitehead assesta un duro colpo allo stomaco. Fatta di sacrifici, sudore e sangue, sia la ferrovia sotterranea vera sia quella fantastica, sono “Il trionfo segreto che ti porti nel cuore”.
Un tema attualissimo, “politicamente consapevole” che sottolinea quanto profondamente allignato sia ancora il razzismo.
Il viaggio cadenzato dagli annunci delle taglie sugli schiavi fuggiti, tratti dagli archivi della University of North Carolina di Greensboro, e scandito da capitoli intitolati con i nomi dei luoghi e dei personaggi in un gioco di analessi e prolessi, tocca così la Carolina del Sud, la Carolina del Nord, il Tennessee, l’Indiana, infine, il Nord, tramutando forma e contenuto del concetto di libertà.
“Erano andate a letto credendosi libere dal controllo e dagli ordini dei bianchi. Credendo di essere padrone della propria vita. Ma venivano ancora raggruppate e addomesticate. Non pura merce come prima, ma bestiame: da allevare, da sterilizzare. Da chiudere in dormitori che sembravano stie per i polli o conigliere.”
“Il demonio aveva dita lunghe e agili” scrive Whitehead, le catene erano, infatti, di nuova fabbricazione, le chiavi e il cilindro della serratura disegnati secondo gli usi locali, ma ugualmente assolvevano al loro scopo.
È lunga la fuga e stremante il viaggio.
Tutto il mondo pare essere un inferno, riarso, straziato, dannato. Pare sempre di essere giunti ora al “capolinea” ora alla meta anelata. E poi, infine, un carro, e una coperta, ruvida e rigida.
Forse di colore viola.
“Cora fece forza sulla leva del carrello. (…) Trovò un ritmo, pompando con le braccia, gettando tutta se stessa nel movimento. Verso Nord. Stava viaggiando dentro il tunnel o lo stava scavando? Ogni volta che premeva sulla leva con le braccia batteva un piccone contro la roccia, una mazza su un chiodo per fissare le rotaie. (…) Cora si mise alle spalle chilometri di rotaie, si mise alle spalle i finti rifugi e le catene senza fine, il massacro della fattoria dei Valentine. Esisteva solo il buio del tunnel, e da qualche parte davanti a lei, un’uscita. O un vicolo cieco, se era questo che aveva decretato il destino: solo una parete vuota e spietata. L’ultimo, tragico scherzo. (…) Si fidò del fatto che la guidava l’unica alternativa dello schiavo: ovunque, ovunque tranne che da dove stai scappando. Il criterio che l’aveva condotta fin lì. Avrebbe trovato la fine dei binari o ci sarebbe morta sopra.”