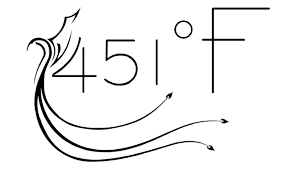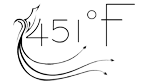«C’era una volta un prigioniero… No: c’era una volta un bambino… Meglio ancora: c’era una volta una Poesia…
Anzi, facciamo così: c’era una volta un bambino che aveva il papà prigioniero.
“E la Poesia?” direte voi. “Cosa c’entra?”
La Poesia c’entra perché il bambino l’aveva imparata a memoria per recitarla al suo papà, la sera di Natale. Ma, come abbiamo spiegato, il papà del bambino era prigioniero in un Paese lontano lontano.
Un Paese curioso, dove l’estate durava soltanto un giorno e, spesso, anche quel giorno pioveva o nevicava. Un Paese straordinario dove tutto si tirava fuori dal carbone: lo zucchero, il burro, la benzina, la gomma. E perfino il miele, perché le api non suggevano corolle di fiori, ma succhiavano pezzi d’antracite. Un Paese senza l’uguale, dove tutto quello che è necessario all’esistenza era calcolato con cosi mirabile esattezza in milligrammi, calorie, erg e ampère, che bastava sbagliare un’addizione – durante il pasto – per rimanerci morti stecchiti di fame.
Stando cosi le cose, arrivò la sera della vigilia, e la famigliola si trovò radunata attorno al desco, ma una sedia rimase vuota».
La sera di Natale del 1944, nel campo di concentramento di Sandbostel, un prigioniero narra una storia ispirata dalle tre muse Freddo, Fame e Nostalgia. Viene musicata e accompagnata dal coro degli altri internati. È una favola raccontata al vento, incaricato di riferire quelle parole, cariche di amore e malinconia, a tutti i bambini, a tutte le mamme, a tutte le nonne.
Nasce così La Favola di Natale (BUR) di Giovannino Guareschi.
La storia di un viaggio magico, onirico e avventuroso intrapreso da Albertino, insieme con il suo cane Flik, la nonna, e la Lucciola, per incontrare il papà lontano.
La storia di un commovente sogno di libertà e speranza.
«È successo d’estate , molti anni fa.
Tra le nebbie che affollano, adesso i miei pensieri di vecchia, una luce rischiara una piccola porzione di mondo.
Chiudo gli occhi e rivedo, intatta, la bellezza radiosa della campagna. Riesco a distinguere ogni dettaglio, nel fremito delle ciglia, colpite dai raggi obliqui del mattino.
Avevo dieci anni, e il mondo stava per affondare nell’abisso. Ma per me era solo estate e campagna.
La più bella estate della mia vita».
Dedicato alla madre scomparsa nel 2014, cui la voce narrante, protagonista, si ispira, L’estate dell’incanto (Piemme) di Francesco Carofiglio racchiude tutta la poetica di cui l’autore barese è capace. È l’estate del 1939, una stagione ambientata in un territorio estatico, dove tutto può accadere, che corre come un filo tra un prima e un dopo la deflagrazione della guerra.
Corre tra le due vite di Miranda che, sempre bambina, attraversa quella cesura che coinvolgerà il mondo intero.
C’è la spensieratezza dell’ultima volta, lo stupore, motore del racconto, c’è la perdita, il dolore, c’è la saggezza dell’età, la fatica del presente, ma anche la curiosità immutata. E c’è ancora l’incantesimo nella rievocazione del ricordo di quell’estate.
«”Come ti paiono queste orecchie?” sentì chiedere.
La voce era grave e seria. Non sapeva da dove venisse, ma sembrava molto vicina.
Era la prima volta che udiva un suono.
“E ora faccio gli occhi”. All’improvviso gli apparvero forme e colori.
L’uomo fece un passo indietro per ammirare la propria opera e poi gli praticò due buchi al centro della faccia. Nuove sensazioni lo invasero: gli odori caldi dell’estate, essenze e profumi avvolgenti. Con gesto esperto l’uomo sfoderò un coltello e fece un’incisione sotto i buchi del naso, regalandogli un bel sorriso. Tirarono fuori da una bisaccia un abito simile al loro, lo imbottirono di paglia finché non raggiunse il volume desiderato e gli infilarono due vecchi stivali di pelle colorati con un nastro blu. Una mano afferrò la sommità del suo cranio e lo fissò al corpo di paglia. “Questo fantoccio spaventerà per bene i corvi! Sembra davvero un uomo”.
“Ma è un uomo!…” borbottò quello con la voce grave, infilandogli un vecchio cappello in testa».
«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» sosteneva Calvino. E Il Mago di Oz di L.F.Baum, ora per Rizzoli nella nuova rilettura di Sébastien Perez e illustrato da Benjamin Lacombe, rende pienamente omaggio a tale considerazione. Pur mantenendo sottesa alla narrazione la metafora e l’aspra critica alla società americana dell’epoca, Perez conferisce un’aura più poetica alle avventure della piccola Dorothy e dei suoi compagni di viaggio nel magico Regno di Oz, il cagnolino Totò, lo Spaventapasseri (qui voce narrante), l’Uomo di latta e il Leone. Tutti alla ricerca di qualcosa che in realtà si cela dentro se stessi, i personaggi esprimono la bellezza dei valori del riconoscimento e dell’accettazione della diversità, della solidarietà e della compassione.
Un racconto sempre attuale e magico che grazie anche alle splendide illustrazioni, colma l’animo e l’occhio di grandi e piccoli.
«La cosa più strana di quello strano viaggio fu che venne inaugurato da una parola – non una parola particolarmente evocativa, bensì un banale conio linguistico ampiamente in uso dal Cairo a Calcutta. Si trattava di ‘bundool’, che significa “arma fa fuoco” in molte lingue, inclusa la mia, il bengali o bangla, e non è estranea neppure all’inglese: attraverso l’uso coloniale è arrivata fino all’Oxford English Dictionary, dove è riportata col significato di “fucile”. Ma non c’erano né pistole né fucili il giorno in cui il viaggio ebbe inizio, né la parola intendeva riferirsi a un’arma. E fu questo il motivo per cui catturò la mia attenzione: perché il fucile in questione era parte integrante di un nome, Bonduki Sadagar, che si potrebbe tradurre come “mercante di fucili” ».
Un saggio sulla migrazione e sul cambiamento climatico incastonato in un avvincente romanzo d’avventura è L’isola dei fucili (Neri Pozza) di Amitav Ghosh.
Abile narratore, l’autore indiano tesse con maestria i fili di un racconto profetico, attuale e globale, allignante le proprie radici nei secoli tra folklore, miti e leggende.
Da Calcutta a Venezia (“destinata forse a finire sommersa”!), da Los Angeles al Bengala, il mirabolante viaggio intrapreso dal protagonista – un commerciante di libri rari e oggetti d’antiquariato, d’origine bengalese trasferitosi a Brooklyn – alla ricerca di un leggendario “mercante di fucili”, è rivelatore dell’ormai irreversibile guerra tra profitto e Natura.
«Caro L’ettore, prima vorrei dire, scusa perle parole che scrivo male.
Perché sono una volpe! Cuindi non scrivo propio
Perfetto. Maecco comò in parato ha parlare e scrivere
bene così!»
A parlare è Fox 8, la Volpe n. 8 della sua esigua tribù. Ascoltando, nascosta, le fiabe della buonanotte narrate da una mamma al suo bambino e le conversazioni degli adulti, ha appreso foneticamente la lingua degli humani, adottando, così, un idioma sui generis.
Dopo il dolente e originalissimo Lincoln nel Bardo George Saunders torna con un testo altrettanto iconoclasta, Volpe 8 (Feltrinelli), una favola dalle tinte noir rivolta principalmente agli adulti e impreziosita dalle illustrazioni di Chelsea Cardinal.
È un breve apologo ora ironico, ora poetico, ora amaro, brutale e drammatico, ora, commovente e di una sconcertante attualità (la sua stesura risale al 2013), strutturato in forma di lettera rivolta al mondo scritta da una volpe, simpatica e sognatrice, che racconta del rapporto tra il mondo umano e il mondo animale e naturale, lanciando un monito sull’operato disumano del primo.
«Cosa c’è che non va in voi, gente?».
«Ero in piedi e l’ho visto contro luce davanti alla finestra . Ho abbassato gli occhi che avevo riaperto.
Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia gli uomini.
Le sue prime parole sul mio spavento sono state: “Shalòm Miriàm”.
Prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto, penetrato nella stanza, quelle parole mi hanno tenuta ferma:
“Shalòm Miriàm”, quelle con cui Iosef si era rivolto a me nel giorno del fidanzamento.
“Shalòm lekhà”, avevo risposto allora.
Ma oggi no, oggi non ho potuto staccare una sillaba dal labbro. Sono rimasta muta.
Era tutta l’accoglienza che gli serviva, mi ha annunciato il figlio.
Destinato a grandi cose, a salvezze, ma ho badato poco alle promesse.
In corpo, nel mio grembo si era fatto spazio.
Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata
Nell’incavo del ventre».
Non credente, ma non ateo, assiduo frequentatore delle Sacre Scritture – lette infinite volte – Erri De Luca ne In nome della madre (Feltrinelli) racconta la storia di Miriàm/Maria.
Ebrea di Galilea, “operaia della divinità”, la ragazza per la prima volta riporta, con limpido ossequio, la propria versione, narrandola in prima persona.
Una versione gravida di amore, di devozione, di fede, di solitudine, per un’attesa inaugurata da una voce e da un figlio che giungono col passo di una sferzata del Maestrale di marzo.
Un piccolo gioiello cesellato dalla lirica penna dell’autore napoletano.
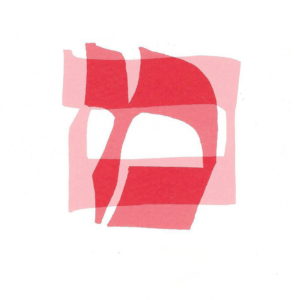 «In ebraico esistono due emme, una normale che va in qualunque punto della parola
«In ebraico esistono due emme, una normale che va in qualunque punto della parola
e una che va solo in ultima casa.
Miriàm ha due emme.
Una di esordio e una terminale.
Hanno due forme opposte.
La M finale è chiusa da ogni lato.
Quella iniziale è gonfia e ha un’apertura verso il basso: è incinta»
«Gli uomini sono buoni a fare qualche mestiere e a chiacchierare,
ma sono persi davanti alla nascita e alla morte.
Sono cose che non capiscono.
Ci vogliono le donne al momento della schiusa e all’ora di chiusura»
[In nome della madre]
Erri De Luca