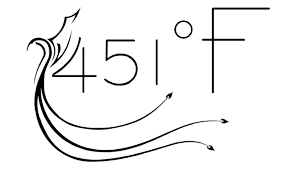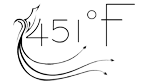Lo schiavista
di Paul Beatty
Vincitore del Man Booker Prize 2016
~ “Hominy”
~ “Zì, badrone?”
~ “Cosa mi sussurreresti all’orecchio?”
~“Che stai pensando troppo in piccolo.
Che salvare Dickens un negro alla volta parlando per megafono non funzionerà mai.
Che devi pensare più in grande rispetto a tuo padre.
Conosci il detto ‘Non puoi vedere il bosco guardando gli alberi’?”
~“Certo”.
~“Be’, devi smetterla di considerarci come individui, perché in questo momento, badrone, non riesci a vedere la piantagione guardando i negri”.
 “Dicono che non è facile essere un ruffiano. Be’, non lo è nemmeno essere un padrone di schiavi. Come i bambini, i cani, i dadi, i politici che si riempiono la bocca di promesse e a quanto pare anche le prostitute, gli schiavi non fanno quello che gli si dice. E quando il tuo servo nero ultraottantenne è in grado di svolgere al massimo un quarto d’ora di lavoro vero e proprio al giorno e gode come un matto a farsi punire, non riesci nemmeno a usufruire delle prerogative da proprietario di piantagione che si vedono nei film. (…) Ero il proprietario di un vecchio nero avvizzito che sapeva una cosa soltanto: quale fosse il suo posto. (…) Perciò, credetemi, la schiavitù è un impegno particolarmente frustrante.”
“Dicono che non è facile essere un ruffiano. Be’, non lo è nemmeno essere un padrone di schiavi. Come i bambini, i cani, i dadi, i politici che si riempiono la bocca di promesse e a quanto pare anche le prostitute, gli schiavi non fanno quello che gli si dice. E quando il tuo servo nero ultraottantenne è in grado di svolgere al massimo un quarto d’ora di lavoro vero e proprio al giorno e gode come un matto a farsi punire, non riesci nemmeno a usufruire delle prerogative da proprietario di piantagione che si vedono nei film. (…) Ero il proprietario di un vecchio nero avvizzito che sapeva una cosa soltanto: quale fosse il suo posto. (…) Perciò, credetemi, la schiavitù è un impegno particolarmente frustrante.”
Provocatorio, grottesco, feroce, caustico, lacerante, audace, difficile. Appellato da un florilegio di aggettivi, Lo schiavista di Paul Beatty (Fazi Editore), vincitore del National Book Critics Circle Award 2016 e del Man Booker Prize 2016, il più prestigioso riconoscimento letterario anglosassone, è una vertigine. Lo è nella sua accezione più stretta. Destabilizza, facendo vacillare l’equilibrio soprattutto laddove la convinzione che lo spirito satirico abbia guidato la penna dell’autore viene tradita quando egli stesso lo nega.
Il venduto (The Sellout è infatti il titolo originale), la cui prosa per sortire l’effetto desiderato non poteva che essere brillantemente e comicamente cruda e scurrile, è una lunga riflessione sulla razza, sulla giustizia sociale e sulla condizione degli afroamericani. Una riflessione che attraversa la storia, la letteratura, il cinema, arenandosi nella contemporaneità o meglio sprigionando un parossismo di cliché sulla razza confermati dall’attualità e (apparentemente) sovvertiti dal tono diegetico.
Sopravvissuto agli “shoccanti” esperimenti cui il padre, studioso in scienze sociali e fondatore della Psicologia della Liberazione (l’uomo che sussurrava ai negri) lo sottoponeva, laureato in Zootecnia e in Agraria, fidanzato con una tetragona autista di autobus con la quale condivide l’amore per Kafka, Bonbon, il protagonista, dopo una serie di accadimenti si lancia in una nuova professione: urbanista della restaurazione e della segregazione razziale di Dickens, periferico ghetto di Los Angeles, “l’ultimo baluardo dell’identità nera“. Tanto “se non avesse funzionato, avrebbe sempre potuto tornare a fare il nero”. Un (in)verosimile esperimento, cascame storicistico identitario. Sottotesto: ripristinare la schiavitù per ridare identità alla comunità nera.
Un flusso di coscienza prende così fiato per bocca dello schiavista (inizialmente schiavista per caso), cedendo la parola ora allo schiavo, Hominy (lo schiavo per scelta, l’ultimo sopravvissuto delle Simpatiche Canaglie), ora agli intellettuali del ghetto, i Dum Dum Donut, e ora alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America dinnanzi alla quale strafatto “come un cavallo” è chiamato a rispondere di quanto commesso.
Sono eterni, scomodi e inevasi gli interrogativi che quella voce tracimante solleva. Interrogativi inerenti i concetti forse utopici di uguaglianza e integrazione.
Il padre invitava Bonbon a porsi due domande: “Chi sono io? E come faccio a diventare me stesso? Ero perso com’ero sempre stato e stavo pensando seriamente di demolire la fattoria, sradicare le colture, vendere il bestiame e installare una gigantesca piscina di lusso con le onde artificiali. Quanto sarebbe stato fico fare surf in cortile?”