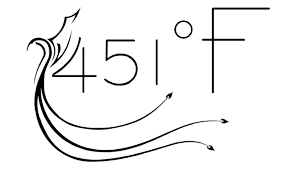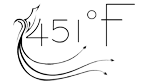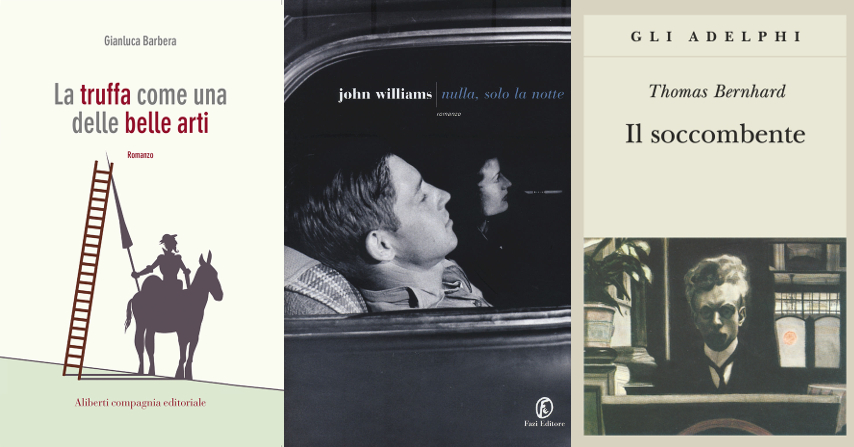Tredici incontri, diciotto ore di registrazione e sei taccuini fitti di appunti per arricchire l’elenco delle belle arti annoverandovi l’ottava: la truffa.
È l’arte che Carl Peter Lopiccolo, alias Dan Alighieri, Francis Petrarca, Johnny Boccaccio, amante di storia antica e di filosofia, e parte attiva di una dinastia di truffatori catanesi, racconta a Riccardo Maria Ricci, giornalista e ora biografo, incaricato da una casa editrice di scriverne la storia. Romanzo nel romanzo, La truffa come una delle belle arti è il titolo che dà corpo alle epiche e picaresche gesta dei Lopiccolo a partire dal 1842, con il capostipite Pepè, sino ad oggi, con la progenie di Carl, in un inanellarsi di inganni, da quelli circensi a quelli finanziari, di illusioni, prestidigitazioni o meglio di prestigiazioni della realtà.
“Il vero truffatore – recita la seconda di copertina – è una sorta di Don Chisciotte rovesciato: l’ingegnoso hidalgo desiderava assolutamente credere vere le favole dei libri di cavalleria; il truffatore fornisce la materia prima a chi cerca qualcosa da credere assolutamente vero.”
Ed essendo assolutamente vero spesso quanto si desidera sentirsi dire, il truffatore assume, quindi, le fattezze di “benefattore”, di filantropo dispensatore di quella che Diderot definisce l’unica passione esistente, ossia la ricerca della felicità: inducendo l’uomo a credere, a fidarsi, ad affidarsi, in un mondo in cui realtà, menzogna, illusorietà e fallacia sono compagne di merenda.
Gianluca Barbera con La truffa come una delle belle arti (Aliberti compagnia editoriale) riproduce ironicamente un grande bluff, un molossoide bluff in cui mariuoli, millantatori e ipocriti occupano i gangli di sistemi manipolatori istituzionalizzati.
Anni Cinquanta. Salisburgo. Tre giovani pianisti seguono un corso di Horowitz. Due sono veri talenti, il terzo, godendo del dono del virtuosismo, è un genio, superando proverbialmente il maestro. Glenn Gloud è il genio, Wertheimer e l’io narrante sono i suoi compagni/colleghi che assistendo alla sua esecuzione delle Variazioni Goldberg prendono coscienza dell’inizio della propria agonia musicale. L’uno trincerandosi nella “scienza dello spirito” giungerà a togliersi la vita, l’altro conchiuso nel suo “processo di intristimento” comprenderà il valore della capacità di cogliere l’unicità dell’essere.
Strutturato come un lungo monologo interiore e un flusso di coscienza che vomita elucubrazioni sul destino del “triangolo pianistico” (a giochi già terminati), Il soccombente (Adelphi) di Thomas Bernhard è un’aspra riflessione (parzialmente autobiografica) sull’invidia, sulla gelosia, sulla fragilità dell’animo, sull’essere ed il non riuscire ad essere.
Il soccombente – nella fattispecie Wertheimer benché anche la voce narrante non sia esente dal sentimento di acrimoniosa débâcle – “è un tipico uomo da vicolo cieco, mi dissi, ogni volta che usciva da un vicolo cieco entrava in un altro vicolo cieco. (…) Il soccombente è già stato messo al mondo come soccombente, pensai, è stato da sempre il soccombente, e se osserviamo con puntigliosa attenzione il mondo che ci circonda stabiliamo che questo mondo è composto quasi esclusivamente da uomini che soccombono come lui, mi dissi. (…) Facciamo una grandissima fatica per salvarci da questi soccombenti e da questi uomini da vicolo cieco, poiché questi soccombenti e questi uomini da vicolo cieco ce la mettono tutta per tiranneggiare il mondo che li circonda e uccidere a poco a poco le persone che li frequentano, mi dissi. Per deboli che siano, e proprio perché la debolezza è radicata profondamente nella loro natura e costruzione, essi hanno la forza di esercitare sul mondo che li circonda un effetto devastante, pensai.”
L’assenza per lunghi periodi di segni di interpunzione e l’iterazione ossessiva dei concetti e dei pensieri, ricorrendo anche all’impiego di anacoluti, rendono quest’opera ancora più tagliente e spietata.
«Era certo che anche nei suoi viaggi ‘d’affari’ il ricordo avesse sempre inseguito suo padre, come un animale famelico insegue la preda ferita. Quali erano i suoi pensieri in quelle lunghe notti calde, in cui dormire era impossibile, in cui giaceva su un letto umido di sudore, in qualche stanza anonima di qualche paese straniero? Forse si rigirava sotto le lenzuola, ripensando a un’altra notte di tanto tempo prima? Forse quelle immagini familiari si levavano dalle tenebre soffocanti per spaventare e tormentare anche lui? “Correre, sempre correre”, pensò. “Fuggire interminabilmente, giorno dopo giorno, senza mai riuscire a scappare.”», si domanda Arthur Maxley osservando il volto del padre, una figura oramai sbiadita della sua vita, come del resto quella della madre. I ricordi di un’infanzia amara rincorrono l’esistenza del protagonista di Nulla, solo la notte (Fazi Editore), romanzo d’esordio di John Williams, dove seppur in nuce emerge già il suo stile chirurgico e puntuale. Qui è rappresentata una giornata del giovane borghese californiano, 24 ore in cui, soprattutto la notte – onirica – che fonde presenze attuali e passate, esacerba la perdita del “centro” (qualora egli ne sia mai stato in possesso).
“La storia non è che una sfilata di falsi assoluti, di tempi innalzati a dei pretesti. E la cosa buffa è che perseveriamo. Ci viene fatto credere che esistano grandi uomini, quando invece in giro non si vedono che dei nanetti. La vita è una presa in giro, ammettiamolo…”
[Emil Cioran
La truffa come una delle belle arti]
Gianluca Barbera